Interviste docenti
Nicola Eynard
Architetto, libero professionista, vive e lavora a Bergamo. Svolge la professione dal 1989 ed è autore o co-autore di numerosi progetti e realizzazioni di opere edilizie pubbliche e private, di tipo sociale e abitativo, caratterizzate da una specifica attenzione ai temi dell’accessibilità, della fruibilità per tutti e del comfort ambientale. Collabora da 25 anni con enti pubblici, operatori privati e associazioni che si occupano del rapporto tra disabilità e spazio fisico.

Partiamo dalla sua biografia: che cosa l’ha portata a scegliere l’architettura come ambito di specializzazione? Che cosa l’appassiona di più del suo lavoro?
Da ragazzo ero molto interessato alla storia dell’arte e alla storia delle città, all’urbanistica più che all’architettura, anche se poi sono finito a fare per lavoro l’architetto. In realtà il mio sogno sarebbe essere un urbanista. La cosa che mi piace del mio lavoro e la cosa che mi ha spinto a fare questi studi è che l’architettura è legata alla vita delle persone: progettare gli spazi e i luoghi dove le persone si trovano a vivere, dove le persone abitano, mi interessa proprio nella misura in cui mi interessano le persone, l’umanità.
Tra i numerosi progetti che porta avanti con il suo studio Habilis uno dei principali fili conduttori è il tema dell’accessibilità e delle barriere architettoniche. Di che cosa si tratta in sintesi (differenza tra accessibilità e inclusione)?
Le barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli e quelle difficoltà che le persone possono incontrare nel muoversi e nello stare nello spazio fisico. I progetti che facciamo cercano di eliminare queste barriere architettoniche o non produrne per fare in modo che gli spazi siano completamente accessibili a tutti. Uno spazio inclusivo, oltre a essere accessibile, ha qualcosa in più, mi spiego con un esempio: rendere accessibile una scuola media significa fare in modo che le persone con difficoltà motorie riescano a entrare a scuola, un ragazzino che si muove in carrozzina per esempio. Un progetto di accessibilità potrebbe consistere nel realizzare sul retro della scuola uno scivolo. In questo modo la scuola diventa accessibile, però forse non è una scuola inclusiva perché il ragazzino in carrozzina deve entrare da un ingresso secondario, separato dagli altri quindi in qualche modo discriminato. Per fare in modo che la scuola sia inclusiva occorre che l’accesso che usano tutti sia praticabile anche per il ragazzo in carrozzina in modo che sia incluso nella comunità degli studenti.

Bergamo è una città inclusiva dal punto di vista architettonico?
Bergamo è una città antica che ha diverse cinte fortificate, le più famose sono le mura veneziane ma ce ne sono altre. È stata costruita in collina e quindi è stata pensata per essere meglio difesa e più difficile da penetrare. Le città storiche sono poco inclusive per natura, cercano di escludere gli stranieri, i possibili nemici e i pericoli in generale. Direi che soprattutto negli ultimi anni si sta facendo molto per cercare di rendere Bergamo una città più accessibile e anche più inclusiva. Per esempio si stanno studiando degli interventi per fare in modo che la passeggiata sulle mura possa essere percorribile da tutti. Sono stati già fatti degli interventi a Porta S. Agostino e tra poco verranno fatti a Porta S. Giacomo, in modo che chiunque possa raggiungere Bergamo Alta e fare la passeggiata delle mura in sicurezza, insieme agli altri. Inoltre lungo i marciapiedi della città di Bergamo ci sono, in vari punti, degli inserti di pavimentazione in rilievo, di colore diverso rispetto all’asfalto. Si chiamano tecnicamente “pavimenti tattilo-plantari” e sono fatti per aiutare le persone cieche o ipovedenti a orientarsi e a muoversi in città. Anche questo è un intervento che va nella direzione dell’accessibilità e dell’inclusione.
Qual’è lo spazio, l’edificio o addirittura la città che lei ha trovato molto fruibile dal punto di vista dell’accessibilità? Che caratteristiche deve avere?
Prima citavi il nord Europa e sentendo questa domanda mi vengono in mente alcune città dei paesi scandinavi: Göteborg, Copenaghen per esempio. Lì ciò che caratterizza le città e in particolare gli edifici pubblici è che sono pensati perché venga garantito a chi li frequenta un certo grado di comfort, di benessere ambientale. Sono luoghi accoglienti. In Scandinavia ci sono stati architetti come Alvar Aalto, Gunnar Asplund, Sverre Fehn che si sforzano sempre di creare luoghi accoglienti, dove per esempio ci siano panchine con sedute comode e confortevoli e banchi dei locali ad altezze diverse in modo tale da consentire a tutti di avvicinarsi. C’è un grado di sensibilità e consapevolezza che non ho visto da nessun’altra parte. In Italia mi vengono in mente città come Ferrara che, per esempio, pur essendo una città storica, ha il vantaggio di essere in pianura e a Ferrara c’è un’università in cui ci sono professori che hanno questa prospettiva e questa visione di un’architettura inclusiva. C’è un’attenzione e un rispetto nei particolari, nei dettagli che fanno la differenza.

Quindi secondo lei è una questione di mentalità o si tratta di modelli di riferimento diversi rispetto al nord Europa (privilegiamo l’aspetto estetico su quello pratico)?
C’è forse una mentalità diversa dal punto di vista storico-sociale, poi forse ciò che fa la differenza sono i soldi: i Paesi del nord sono più ricchi e quindi hanno già risolto altri problemi strutturali che per noi sono ancora un ostacolo quotidiano e sono già passati a risolvere questi problemi di carattere architettonico. In realtà in Italia non mancano le leggi a favore dell’accessibilità. C’è una normativa tecnica molto puntuale, forse fin troppo. Ci sono un sacco di leggi e a volte è difficile orientarsi anche per un professionista. Le barriere principali alla fine sono proprio quelle culturali, quelle insite in ognuno di noi che non ci permettono di guardare le cose dal punto di vista degli altri. Per esempio le persone che parcheggiano la macchina a cavallo del marciapiede e impediscono ai pedoni di passare creano una barriera architettonica e lo fanno perché nella loro testa c’è una barriera culturale.
Grande protagonista della pandemia che da più di un anno condiziona le nostre vite è la casa, l’ambiente domestico. Molto spesso spazi stretti e angusti che inducono all’isolamento o che non agevolano il telelavoro pongono un interrogativo importante: è necessario ripensare i modelli abitativi sia per la singola abitazione sia per il tessuto urbano?
La casa è diventata una grande protagonista delle nostre vite perché stiamo in casa molto di più e questi cambiamenti nell’uso della casa che si stanno determinando in realtà, forse, erano iniziati già prima della pandemia. Secondo me la pandemia ha accelerato dei processi come quello del telelavoro, del potersi incontrare anche senza vedersi fisicamente che c’erano già, ma non venivano molto utilizzati. Direi che la necessità di rendere lo spazio domestico sempre più flessibile e modificabile facilmente nel tempo a seconda delle esigenze è un tema che gli architetti e gli arredatori si pongono da tempo. Adesso il processo si sta accelerando e anche la tendenza, molto presente negli anni scorsi, di creare spazi abitativi sempre più piccoli si sta un po’ rivedendo perché ci si accorge che se in questi spazi minuscoli siamo costretti a starci molto tempo, magari con altre persone, si fa parecchia fatica. Quindi ora si pensa a spazi più ampi, si rivalorizzano i balconi e i terrazzi, se possibile si sfruttano i giardini e tutti quegli spazi flessibili, adattabili alle esigenze. È una bella sfida che però merita di essere affrontata.

A questa tendenza che voleva spazi minuscoli iper-attrezzati si contrappone una nuova concezione dell’abitare che sta prendendo piede…
Sì, si tratta del “cohousing”, letteralmente “co-abitare”. Consiste nel cercare di superare il modello della cellula abitativa autosufficiente in cui uno sta dentro per conto suo o con il suo ristretto nucleo familiare per accogliere, invece, dei modelli in cui ognuno avrà sempre i propri spazi domestici privati, ma all’interno del condominio o della struttura abitativa possono esserci degli spazi comuni, spazi dove si lavora insieme, lavanderie e cucine comuni. In modo che la gente possa, se vuole, stare con gli altri e avere spazi di condivisione abitativa. Sono esperimenti interessanti e anche in questo caso nel nord Europa ce ne sono molti, ma anche qui a Milano e in generale in Lombardia conosciamo diversi esempi che seguono questa linea.
Quali effetti possono avere le norme di distanziamento sociale nella progettazione di spazi inclusivi? Opportunità o ostacolo?
Io cerco sempre di vedere positivo e quindi quando c’è un elemento esterno che ci costringe a cambiare io cerco sempre di cogliere le opportunità. Può essere un modo per mettere in discussione alcuni schemi mentali che abbiamo e trovare delle soluzioni migliori. Poi non è detto che sia così però il distanziamento sociale favorisce, per esempio, il pensiero di spazi un po’ più ampi e per garantire una migliore accessibilità e inclusione le dimensioni degli spazi sono importanti: per esempio per una persona che si muove sulla sedia a rotelle avere un po’ più di spazio di manovra nei corridoi, negli uffici e nei bagni stessi è fondamentale. Se queste condizioni di distanziamento sociale ci costringeranno a rivedere il calibro degli spazi in cui ci muoviamo otterremo sicuramente grandi benefici.

Che ruolo hanno gli spazi verdi nella progettazione inclusiva?
Direi proprio che hanno un ruolo importante. In questi ultimi anni, già prima della pandemia, le zone verdi sono diventate sempre di più luoghi frequentati, di incontro e aggregazione. Per esempio la Greenway qui a Bergamo è frequentatissima. Si incontrano quasi più persone lì che sul Sentierone. Oppure la ciclabile della Val Seriana che esiste da un po’ di anni ed è diventata per i paesi della bassa e media Val Seriana un punto dove ci si incontra e ci si trova. Luoghi, insomma, sempre più centrali nella vita delle comunità. Credo quindi che sia davvero importante che questi spazi verdi siano progettati in modo inclusivo perché tutti devono poterci andare. Io sono stato consigliere comunale per qualche anno qui a Bergamo e abbiamo lanciato un progetto per rendere inclusiva un’area verde a Celadina, un parco per l’esattezza. I giochi che abbiamo progettato seguivano il modello dell’inclusività: tutti i bambini, indipendentemente dalle capacità motorie, cognitive, sensoriali possono stare e giocare, soprattutto giocare insieme agli altri. Negli ultimi anni si sono riempiti i parchi giochi di mezza Italia con quelle altalene così dette “accessibili”, quelle con la pedana su cui si può salire con la carrozzina. Ecco, queste sono cose che, a mio avviso, non vanno bene perché l’altalena diventa sì accessibile, ma per nulla inclusiva perché la possono usare solo i bambini in carrozzina. Poi succede, inevitabilmente, che ci giochino anche gli altri bambini e magari si fanno male o la danneggiano. Invece bisogna pensare a dei giochi, dei percorsi, delle pavimentazioni che permettano a tutti di vivere quei luoghi.
Quale è il progetto portato avanti dal vostro studio Habilis con questi criteri di accessibilità che ricorda con più piacere?
Il primo che mi viene in mente è un progetto ormai concluso di qualche anno fa in cui veramente mi sono appassionato. Si tratta di un grande progetto di un villaggio realizzato in un paese della Bassa Bergamasca, si chiama “Villaggio Solidale”. Consiste in quattro edifici con spazi aperti e spazi di condivisione strutturato in modo tale da favorire l’accoglienza delle persone fragili: ci sono alloggi per l’autonomia, abitati da persone che stanno cercando di intraprendere un percorso di vita autonomo supportate da altre persone, alloggi per famiglie che accettano di prendere bambini in affido e una comunità alloggio per minori. Si tratta quindi di un progetto che ha al cuore i minori e il ripristino della loro inclusione all’interno di una comunità. Ci sono poi altri spazi come un centro diurno per persone con disabilità, una grande sala polifunzionale con cucine comuni. Insomma, il tempio dell’inclusione e dell’accoglienza che sta tuttora funzionando bene.
Lei oltre a essere un docente per Terza Università, ha anche avuto la possibilità con altri colleghi del suo studio di progettare dei laboratori a tema “inclusività” per bambini e ragazzi: quale esperienza laboratoriale ricorda con più piacere?
Abbiamo avuto esperienze di questo tipo con ragazzi piccoli delle medie o addirittura della primaria, ma anche con ragazzi più grandi degli istituti tecnici, soprattutto geometri o ragazzi del liceo artistico. Si trattava di esperienze di formazione per ragazzi che avrebbero poi creato dei progetti. Quindi cercavamo di incanalare la loro attenzione sull’accessibilità e l’inclusione come elementi da includere all’interno del loro lavoro. Abbiamo fatto dei laboratori, per esempio all’istituto Quarenghi di Bergamo, in cui invitavamo i ragazzi a fare progetti per rendere accessibile e inclusiva la propria scuola. In questo modo abbiamo cercato di farli riflettere sul cambio di prospettiva che bisogna avere quando si progetta e il tipo di sguardo critico che occorre avere anche e soprattutto su un luogo che si è abituati a frequentare quotidianamente.

Come è cambiata la sua vita in questo anno di pandemia?
È un periodo difficile per tutti e lo è anche per me, sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista della vita sociale. Però è anche un periodo in cui ho imparato un sacco di cose nuove. Un po’ tutti siamo stati costretti a diventare più spigliati con la tecnologia e reinventarci per fare uno scatto di crescita verso una società sempre più smart. Poi dal punto di vista personale la mia vita era già cambiata da più di un anno perché i miei figli sono grandi e sono usciti di casa e a un certo punto è uscita di casa anche mia moglie perché è andata a lavorare in Albania! Quindi viviamo insieme solo quando io riesco ad andare là e quando lei torna a Bergamo. Però con la pandemia spostarsi è ovviamente più difficile.
Che consiglio e che augurio si sente di dare ai soci di Terza Università per affrontare questo periodo così complesso?
Auguro a tutti di poter essere vaccinati il prima possibile! Poi consiglio di portare pazienza e prendere questo periodo storico come una sfida, come un’opportunità per mettersi in gioco e imparare cose nuove. Infine consiglio di essere particolarmente affettuosi con i nipoti: i ragazzi sono quelli che, silenziosamente, stanno soffrendo di più in questa situazione.
Micaela Bianco
Micaela Bianco fisioterapista di professione inizia a praticare la Biodanza nel 1998. Nel 2002 si titola come insegnante presso la Scuola di Formazione di Biodanza, Sistema Rolando Toro di Padova. Successivamente si specializza in Biodanza per bambini e adolescenti – Biodanza acquatica – L’Identità e i 4 elementi – Biodanza e integrazione del femminile – L’albero dei desideri – Voce, musica, percussioni – Progetto Minotauro – La Parola in Biodanza – Biodanza clinica. Dal 2002 conduce corsi settimanali e stages di Biodanza® per adulti, per bambini, per gruppi con disagio mentale, per operatori sociosanitari, per gruppi di donne.

Partiamo dalla sua biografia: quando e come si è avvicinata alla biodanza?
Ho lavorato fino a due anni fa come fisioterapista, questa è la mia base professionale e certamente la ricerca sul movimento è il filo conduttore che lega tutte le attività della mia esistenza. La Biodanza si è affacciata nella mia vita ventitré anni fa. Si trattava per me di una fase esistenziale caratterizzata dalla ricerca di senso: come muovermi nel mondo e nella mia esistenza. Penso che la Biodanza sia una di quelle pratiche che incontri quando sei pronta a incontrarla, almeno per me è stato così. Me ne sono innamorata subito perché mi ha riconnesso con il piacere di vivere e con la percezione di essere “intera”, senza distinzione tra spirito e corpo. È una pratica che favorisce l’esperienza di sé in modo integrato: in Biodanza si utilizza il termine vivencia, che in italiano potrebbe essere reso con “esperienza diretta, nel momento presente”, l’essere presenti nella propria interezza, nel qui e ora. La dimensione di integrità e interezza che questa pratica riesce a dare è unica. Da molti anni ormai mi muovo all’interno del Movimento della Biodanza e da alcuni anni sono alla direzione di una scuola di formazione, in Polonia.
Ci racconti un’esperienza che l’ha segnata da quando ha iniziato questo percorso
Sento di essere stata testimone di molti processi, di passaggi che ho visto accadere nelle persone, nella direzione di un aumento del benessere esistenziale, non solo fisico (sebbene ci sia anche molto movimento del corpo e non ci sia preclusione rispetto all’età o alle difficoltà motorie). Tra le esperienze più significative ricordo quella presso la casa di riposo Carisma, all’interno del Nucleo Alzheimer. Le stesse operatrici che vi lavorano si sono profondamente emozionati nell’assistere alle reazioni dei pazienti che hanno partecipato all’esperienza. Ecco, l’aspetto della meraviglia nella Biodanza arriva in modo subitaneo. Un’altra esperienza toccante è certamente quella con un gruppo di donne operate al seno, dopo la mastectomia: la meraviglia nella riconquista del piacere del proprio corpo, nel ricominciare a sentire la libertà espressiva e il piacere di essere quello che si è, la riconnessione con quello che si sente. E in una dimensione collettiva (la Biodanza è una pratica di gruppo, non individuale) si genera una dimensione di intimità che è nello stesso tempo universale, ci restituisce il senso di appartenenza alla comunità umana, un bellissimo paradosso. Le applicazioni della pratica ai diversi ambiti clinici riescono ad essere spesso estremamente toccanti e significative.
La Biodanza è peraltro nata in ambito psichiatrico: Rolando Toro Araneda, psicologo, antropologo e poeta, il creatore della pratica, negli anni 60’ iniziò proponendola nei reparti psichiatrici, con lo scopo di ricondurre a una dimensione più umana e umanizzante l’approccio ai pazienti. Dalle prime esperienze in questo ambito clinico si è poi aperta e sviluppata come proposta rivolta a gruppi di persone di qualunque età e contesto. Oggi è diffusa in tutto il mondo.

Quali sono i benefici psicofisici che riscontra nelle persone che cominciano ad approcciarsi a questo tipo di percorso
Sicuramente lo stato di benessere che immediatamente la pratica procura. All’inizio la persona fatica a capire la fonte di questo benessere, ma di solito non vede l’ora che arrivi la settimana successiva per l’appuntamento con la Biodanza. Il primo livello di integrazione che le persone sentono ha proprio a che fare con il semplice piacere di fare quello che si fa. La pratica è molto progressiva, e certamente il contatto con l’altro è favorito e facilitato, ma nulla viene forzato o indotto. Ogni sessione di Biodanza è caratterizzata da una profonda organicità, e la struttura organica è riconoscibile a prescindere dal contesto o ambito in cui ogni sessione avviene: si inizia con un momento di attivazione fisica, con la sollecitazione del nostro sistema nervoso simpatico per poi passare gradualmente alla sollecitazione del sistema parasimpatico, fino ad uno stato di rilassamento che prelude infine a una morbida riattivazione finale. Si tratta di un lavoro sull’identità, ma sempre nella dimensione dell’inter-relazione con gli altri. È un lavoro di integrazione con l’altro, come simile, e con l’oltre, come ciò che ci trascende.
Quale è, in sintesi, la o le teorie su cui si appoggia la pratica della biodanza?
Alla base della Biodanza, come dice il termine stesso, c’è la vita nella sua universale interezza e quindi contiene in sé, in un approccio sistemico, molti diversi aspetti teorici: biologia, fisiologia, psicologia, filosofia, mito. Esiste cioè un importante substrato teorico che Rolando Toro ha sempre cercato di difendere da qualsiasi etichetta New-Age che facilmente veniva apposta alla pratica. Si parte sicuramente da un fondamento biologico-organico perché la pratica porta da subito a risultati significativi su questo piano. Attraverso la Biodanza si induce un’autoregolazione organica, si va cioè a stimolare il potenziale di salute proprio di ognuno. Quest’autoregolazione si basa sull’alternanza nell’attivazione dei sistemi simpatico e parasimpatico. Nello stesso tempo la pratica fa leva su una dimensione di rieducazione affettiva perché l’umano, oggi più che mai, ha bisogno di una pedagogia dell’affettività. Innanzitutto ritrovando la comunicazione con sé stesso, dato che sempre più spesso facciamo fatica a riconoscere le nostre emozioni e istinti più profondi. La Biodanza può condurre a una nuova conoscenza di noi stessi come esseri umani.
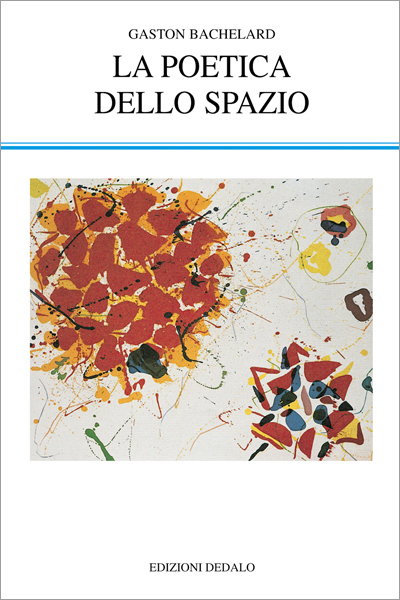
I quattro elementi come forze intrinseche dell’essere umano: come si concretizza questa idea nella pratica della biodanza?
La Biodanza è una pratica che in modo progressivo accompagna processi che possono essere anche molto profondi: il percorso che permette di recuperare la propria libertà di espressione consente parallelamente di cominciare a familiarizzare con le proprie percezioni ed emozioni, per accedere a piani di profondità sempre maggiori. Vengono trattati e, letteralmente, “danzati” alcuni aspetti teorici che possono facilitare l’accesso a parti di noi stessi. La Terra, l’Acqua, l’Aria e il Fuoco sono elementi primordiali della natura. “Ovunque presenti come elementi fisici, come archetipi, come simboli e come nutrimento quotidiano, costruiscono un ponte tra il nostro presente e le radici dell’umanità, tra il nostro corpo e i regni della natura, tra il microcosmo individuale e il macrocosmo del mondo”. Le ricerche sul simbolismo archetipico dei quattro elementi realizzate da Jung e Bachelard consentono un approccio di grande interesse riguardo l’identità delle persone: oltre ad essere gli elementi costitutivi dell’universo, sono interpretabili come quattro forze intrinseche all’essere umano, possono cioè rappresentare aspetti del nostro essere, del nostro carattere, del nostro temperamento, della nostra maniera di vivere, della nostra identità. Ogni individuo ha in sé componenti dei quattro elementi in proporzioni diverse. Le difficoltà dell’esistenza si producono quando qualcuno degli elementi non può manifestarsi. Il Fuoco rappresenta l’impulso, la passione, l’erotico; l’Aria la libertà, il sogno, il respiro, ma anche la distanza dal quotidiano; l’Acqua rappresenta la fluidità, il non incastrarsi in situazioni, lo sciogliere conflitti, la sensualità, il piacere e l’abbandono; la Terra rappresenta, infine, la concretezza, il primordiale, il profondo, le radici. La Biodanza cerca di integrare in noi tutte queste componenti per riuscire a sentirle danzare dentro di sé, nell’umana contraddittorietà.
In che modo la Biodanza può aiutare gli anziani, specialmente in questo periodo di incertezza psico-emotiva e limitazioni del movimento fisico?
Da un anno ormai siamo in questa situazione e sono state bloccate tutte le attività che prevedono l’incontro in gruppo. L’estate scorsa sono riuscita a fare alcune proposte all’aperto, in mezzo alla natura, ma la pratica in palestra resta preclusa. Credo che le persone anziane, le persone in casa di riposo, ma anche gli adolescenti e i giovani, avrebbero veramente bisogno di una pratica come questa per tutto quello che abbiamo detto finora. Io non credo nella pratica della Biodanza attraverso piattaforme virtuali, per me è, e resta, un’attività in presenza, pur con distanziamento e mascherina, ma in presenza. Non si tratta solo di esercizio fisico, ma di relazione, del riappropriarsi di sé in mezzo agli altri.

In che modo è cambiata la sua vita nel 2020? Che lezione sente di aver tratto dopo un anno di pandemia?
Io mi sono fermata e sono rimasta in osservazione, mantenendo, almeno virtualmente, i contatti con le persone che seguivo. È stato un anno di apprendimenti infiniti, il primo lockdown è stato per me una vera vivencia, mi ha catapultato in un’improvvisa esperienza di differente percezione del tempo, uno stato di coscienza espansa molto interessante. Io mi sono abbandonata, sono stata nella fluidità di ciò che accadeva, apprendendo nuove formule per poter riportare fuori questa pratica non appena ce ne sarà la possibilità.
Un augurio e un consiglio ai soci di Terza Università per questo 2021
L’augurio è quello di non mollare, mantenersi aperti alla conoscenza, nella consapevolezza che non smettiamo mai di imparare da tutte le esperienze della vita, quelle positive e quelle negative. E di non cascare nella tentazione di dire “ci è stato rubato un anno di vita” perché, invece, in quest’anno di vita abbiamo probabilmente imparato moltissime cose, non buttiamole via, sono preziose.
Rosa Chiumeo
Nella sua vita da insegnante qual è la lezione più importante che sente di aver appreso?
Io mi sono divertita per quarantadue anni e spero che anche i miei allievi abbiano un bel ricordo di me, se no sarebbe tragico. Il dare e l’avere nel rapporto insegnante alunno secondo me ha bisogno di feeling: se fai una battuta la apprezzano, se ti arrabbi capiscono le tue motivazioni. È stato bello insegnare, è stato un vero piacere.
Il suo lavoro le ha permesso di conoscere diverse generazioni di giovani: come ha letto, nel tempo, l’interesse dei ragazzi verso un percorso artistico e come le sembra che siano cambiati i ragazzi nel corso di questi quarantadue anni di onorato insegnamento?
Io ho giocato a mani basse, ho insegnato al liceo artistico Storia dell’arte e meglio di così non poteva andare. Si tratta di una materia di indirizzo che suscita una grande passione tra gli studenti, primo perché vengono ragazzi motivati, secondo perché moltissime delle altre discipline hanno un taglio artistico forte, sia teorico che pratico, e quindi la Storia dell’arte non solo è gradita ma soddisfa anche quel bisogno di approfondimento estetico che quei ragazzi hanno già spontaneamente. Io durante le gite ero emozionata per la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi. Mi capita di incontrare ex studenti oggi sessantenni che ricordano con nostalgia quei tempi felici. È anche merito dell’ambiente del liceo artistico questa passione intramontabile.
Ci parli dell’esperienza di “Lavorodopo” (associazione culturale nata nel 2004): come è nata e a che punto è oggi
La mia esperienza è nata grazie a Dario, mio marito, (ndr. Il docente di T.u. Dario Franchi) che ci lavorava. L’associazione cercava proposte, io ho inviato le mie e abbiamo cominciato a collaborare proprio mentre Terza Università stava decollando. Mi è piaciuta come esperienza: c’è un’utenza motivata da un sincero interesse. Un bel pubblico quello della Terza Università, vivace e partecipe. Una volta che questo periodo di emergenza sanitaria sarà superato, ho già altri progettini nel cassetto da portare avanti. Credo che il rapporto diretto sia fondamentale, come per la scuola. Quando vedo glii studenti coi banchetti per strada, davanti ai propri licei, sono completamente dalla loro parte. La scuola è fatta di rapporti personali. Quanto sono importanti i compagni di classe per un adolescente? Imporre questa modalità virtuale a lungo andare mi sembra una mancanza di attenzione, un’indifferenza colpevole.
Lei è una grande esperta e appassionata di tutta la storia dell’arte. Oggi però vuole offrire ai soci di Terza università la possibilità di riflettere su un tema che le è particolarmente caro: il nudo classico nell’arte greca. Ce ne parli
Il nudo entra nell’arte con una scelta che è estetica ma anche etica. I Greci sono i primi che propongono dei nudi che ritraggono cittadini o giovani atleti, non faraoni con le insegne del potere. Questi giovani nudi spesso sono degli atleti e rappresentano un ideale di umanità altissimo. I Greci usavano l’espressione καλὸς καὶ ἀγαθός, (kalòs kai agathòs) che vuol dire “bello e moralmente alto”. Quindi quelli rappresentati sono i cittadini ideali, di cui parla anche Platone, quelli che sanno cosa devono fare, giudicano con consapevolezza etica e naturalmente sono bellissimi nel corpo, perché il corpo è la sede di una perfetta armonia. Per esempio, il Poséidon di Capo Artemisio

è un nudo in bronzo, uno dei pochi originali. Poseidone sarebbe colto nel momento in cui lancia il tridente o, secondo alcuni si tratta di Zeus, che quindi lancia fulmini in una posizione straordinariamente atletica, dunque l’atleta è un modello anche per la rappresentazione degli dei. In questo caso il dio è così bello da fare invidia, tratto tipico degli dèi nell’arte greca. Sono belli nel corpo e hanno poteri straordinari, ma soprattutto hanno qualcosa che gli uomini invidiano senza speranza: l’immortalità.
Vi mostro anche altre due immagini, il Discobolo di Mirone e il Doriforo di Policleto, quest’ultimo autore di un canone che purtroppo non abbiamo più, anche se sappiamo di cosa si trattava. Vi erano state individuate le proporzioni armoniche del corpo: la testa che deve essere un settimo del resto del corpo, il polso che deve essere la metà del collo, la sezione aurea ecc.


L’artista crea un modello dove questi rapporti geometrici sono realizzati alla perfezione, eppure non c’è mai forzatura e rigidità, è tutto naturale. Uno guarda queste due sculture notandone i dettagli tecnici, ma innanzi tutto vede un corpo armonioso. Nell’arte classica naturalezza e perfezione coincidono.
Mi sono permessa di mostrarvi anche delle opere contemporanee che fanno riferimento alla classicità con dolore.

Per esempio Claudio Parmiggiani propone una testa di un vivido giallo con gli occhi bendati. È qualcuno che ha subito una tortura, è stato decapitato, metafora di un’arte classica che ha subito tutte queste violenze. Non è più attuale, non è più vivente eppure possiamo ancora guardarla nella sua bellezza solo in modo dolente, nostalgico. Lo stesso vale per il volto sfigurato di Mimmo Jodice: l’arte antica si presenta a noi danneggiata non solo da un punto di vista archeologico, ma anche nella nostra rappresentazione. L’ideale di bellezza è un ideale ferito.

Per non parlare dell’ultima immagine che mi fa piacere mostrarvi: lo scultore è polacco e si chiama Igor Mitoraj. Qui c’è questa grande testa e frammenti di sculture che sono collocate magnificamente a Pompei.

Lo scultore guarda l’antico con grandissimo amore, ma non fa quasi mai opere complete, solo frammenti. Questa testa appoggiata bellissima suscita in noi il rimpianto di un mondo perduto. Da notare anche il diverso ordine di grandezza: Mitoraj fa opere più grandi o più piccole del naturale come a suggerire che l’arte classica è una presenza forte per noi ma non reale. Possiamo guardarla e goderne esteticamente e rimpiangere ciò che abbiamo perduto. In realtà questa cultura classica è molto attuale, ma non nella banalità di un recupero neoclassico (questo mondo è bello e vogliamo essere come loro) ma nel senso di “questo mondo è bellissimo e non è più”. Anche il rimpianto fa parte della nostra cultura.
In letteratura non si è mai spento l’acceso dibattito sul ruolo dello scrittore o poeta: la tendenza attuale è quella di scrivere romanzi e poesie molto intimiste, che guardano all’interiorità di chi scrive. A questa corrente preponderante viene contestato di non essere abbastanza “politica” di non volgersi abbastanza al mondo contemporaneo per darne una possibile chiave interpretativa o per portare alla luce problematiche sociali, economiche e via dicendo.
Questo discorso può valere anche per l’arte contemporanea? (alcuni la giudicano troppo incomprensibile, troppo ermetica per essere compresa, troppo poco “politica”)
L’arte si muove con una disperazione e con una libertà che la caratterizzano fortemente. Nell’arte contemporanea ci troviamo di tutto, ci troviamo anche la politica. Nel 2017 sono andata alla Documenta di Kassel (ndr. una delle più importanti manifestazioni internazionali di arte contemporanea a cadenza quinquennale) che ha la presunzione, a volte fondata, di cogliere le principali tendenze artistiche più di altre manifestazioni, come la Biennale di Venezia. Talvolta ho, in effetti, ritrovato tendenze artistiche quasi “profetiche”. Per esempio una buona parte di Documenta nel 2017 aveva un taglio politico importante: quello delle grandi migrazioni e della condizione urbana, riferimenti a Ulisse e al suo navigare. Da dopo la Seconda Guerra Mondiale l’arte ha un linguaggio globale e i paesi così detti del Terzo Mondo nelle mostre internazionali sono molto presenti, e portano la propria cultura. Già questo è un fatto implicitamente politico. Non sempre si tratta di dichiarazioni terzomondiste o di lotta, ma ci si accorge che occorre misurarsi con culture radicalmente diverse dalle nostre. L’arte europea tende ad avere una carica intellettuale, quindi si diversifica dalla cultura dell’America latina e dell’Africa per esempio. La Cina poi ha mezzi che altri paesi non si sognano neanche e quindi riempie le mostre internazionali con una produzione stupefacente. Vorrei consigliare a quelli che si avvicinano all’arte contemporanea di non pretendere di utilizzare la logica e il buon senso perché sono chiavi di lettura che non funzionano. Piuttosto preferiamo le categorie del “mi piace” “non mi piace”. Non si deve amare tutto, se invece un’opera intriga, lasciamoci prendere. L’arte contemporanea si nutre sia di intellettualismo sofisticato sia di una semplicità di approccio disarmante. Poi a volte ci sono componenti di disperazione, di annullamento. È una varietà infinita, ma non apolitica. Quanto all’incomprensibilità: mah, quanto della realtà che viviamo crediamo che sia comprensibile, certo se guardiamo la pubblicità e le immagini che in genere ci vengono proposte sono tutte molto comprensibili e direi abbrutenti. Forse, allora, è meglio soffrire davanti all’arte che non si capisce.
Cosa resta dell’arte all’epoca di Netflix (il dibattito su arte e cinema sembra ormai superato per via del fatto che anche il cinema sta attraversando una profonda crisi)
Questa domanda, in realtà, si poteva fare anche 150 anni fa quando è nata la fotografia perché ciò ha veramente messo in crisi la pittura, piegandola in ginocchio, costringendola a cercare altre strade: è stata la fotografia, che faceva a prezzo bassissimo, con una fedeltà assoluta dell’immagine originale, quello che la pittura aveva fatto fino a quel momento con una totale egemonia. E tuttavia la pittura ha trovato altre strade: per esempio quella di rappresentare quello che la fotografia non poteva cogliere, il mondo dell’indicibile e dell’invisibile, il mondo interiore dell’artista, il paesaggio deformato dallo stato d’animo dell’artista. Tuttavia la fotografia come il cinema, come Netflix possono essere arte! Io ho visto delle serie tv che sono delle vere opere d’arte. Prevalentemente sono gli inglesi quelli che le sanno fare meglio. La crisi è uno stato permanente. Però la vedo come una crisi vitale, non come un danno e una perdita. Uno stimolo continuo a proporre ciò che né la pubblicità né il mondo della speculazione sono in grado di proporre. In realtà c’è arte dappertutto.
“La bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij, in una delle citazioni più abusate della storia. Tuttavia in che modo secondo lei, se è possibile, l’arte può diventare antidoto alla solitudine e alla sofferenza, specialmente in un periodo di fragilità strutturale come questo?
Questa frase viene veramente citata a proposito e a sproposito da tutti, tant’è vero che c’è un dibattito su quello che voleva dire veramente Dostoevskij: molti insistono nel ritenere che questa “bellezza” di cui parla avesse una valenza più etica che estetica. Indipendentemente da questo, sono tante le cose che possono salvare il mondo: la moralità, l’etica, l’altruismo, la generosità. La bellezza ha il suo ruolo, ma non è prioritaria secondo me. Chi ha esigenze estetiche probabilmente vive meglio, ma può anche essere vero il contrario perché, di fatto, vive peggio in un mondo volgare. Certo poi c’è l’arte terapia che sappiamo ormai essere molto funzionale ed efficace a volte, ma non generalizzerei. Per esempio le mie figlie, che sono stati bombardate di Storia dell’arte da me e mio marito, hanno scelto percorsi totalmente diversi, sono state le nostre “vittime”, come dicono loro. Sicuramente un’educazione estetica è importante, ingentilisce l’animo forse rende anche più felici, chissà. Credo comunque più nel valore dell’approfondimento culturale.
Un augurio e un consiglio ai soci di Terza Università per questo 2021
Abbiate cura di voi! Tenetevi in buona salute: riprenderemo sicuramente.
Piergiorgio Pescali
Piergiorgio Pescali, ricercatore scientifico e fotoreporter, compie i suoi primi reportage nella Cambogia dilaniata dalla guerra civile e nella Birmania governata dai militari. Ha intervistato Pol Pot, e il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, il Dalai Lama. Dal 1996 è uno dei pochi giornalisti a visitare la Corea del Nord. Collabora con diverse testate giornalistiche e radiofoniche in Italia tra cui Avvenire, Il Manifesto, Famiglia Cristiana, Rollingstone, Radio Vaticana, Radio Popolare, Radio24. All’estero collabora con la BBC e la CNN. Nel 2020 ha pubblicato il suo quinto libro, “Versi d’amore e di scienza” edito da Bertoni Editore e a marzo 2021 uscirà un altro libro dedicato al disastro di Fukushima in occasione del decimo anniversario dell’incidente nella centrale nucleare giapponese.

Partiamo dalla sua biografia: come ha coniugato gli studi di fisica con la professione giornalistica in giro per il mondo?
Le due cose, a ben vedere, si intersecano perfettamente l’una con l’altra. Lavorare per i centri di ricerca, i laboratori e partecipare ai convegni mi permette di viaggiare e stabilire in luoghi prettamente non turistici per diversi mesi. Questo quindi mi consente di coniugare il dovere con il piacere e di toccare con mano la situazione di un determinato paese per poi scriverne e proporre i miei articoli o le mie interviste alle nostre riviste e giornali.
Quando è nato e come si è sviluppato l’interesse per i Paesi asiatici e in particolare le nazioni di cultura buddista rette da governi socialisti?
Sono nato e cresciuto in una famiglia molto cattolica e politicamente orientata a destra. Un po’ per reazione, un po’ per amicizie e interesse ho cominciato sin da bambino ad avvicinarmi ad altri mondi, esperienze e culture. Alle elementari ho letto con fervore tutto Salgari e Pearl Buck, alle medie inferiori mi sono avvicinato al buddismo e al mondo asiatico per poi approdare durante le superiori all’esplorazione dell’aspetto più politico di queste regioni del mondo. Era appena finita la guerra del Vietnam, Mao Zedong era morto da pochi anni e a metà negli anni ottanta si cominciava a scoprire cosa era accaduto in Cambogia con Pol Pot. Ho cominciato allora a chiedermi perché un certo tipo di civiltà socialista dagli aspetti così totalitaristici si fosse innestata in paesi dalla tradizione buddista: le due cose, a un primo sguardo, possono sembrare antitetiche. Sicuramente sono molti i fattori e le concause che hanno portato a questa situazione, prima fra tutte il fatalismo che permea il buddismo, specie nel Sudest asiatico. La reincarnazione porta ad accettare le disgrazie della vita associandole al karma. Oggi sei ciò che sei per le azioni che hai compiuto nel passato e nel futuro rinascerai per quello che farai nel presente. Inoltre in Asia c’è una forte empatia verso l’altro, verso il prossimo, si è in generale più orientati a pensare rivolti verso il collettivo a differenza di quando siamo abituati noi, più individualisti.
La Corea del Nord: per l’opinione pubblica italiana equivale a un grande buco nero nel planisfero e la sua rappresentazione da parte dei media occidentali è spesso farsesca se non addirittura parodistica. Lei invece dal 1996 è uno dei pochi giornalisti a visitare regolarmente la Corea del Nord e quindi a riuscire a percepire il cambiamento avvenuto a partire dal 2011 con l’avvento al governo di Kim Jong Un. Ci spiega sinteticamente che cosa è avvento sul piano socio-politico ed economico?
La Corea del Nord è sempre stata politicamente isolata. Verso la fine del secolo scorso abbiamo assistito a un’apertura prima timida poi sempre più decisa proveniente proprio da questo Paese. Anche durante le contestazioni del Sessantotto la Corea non ha mai suscitato l’interesse che invece era rivolto verso la Cina o verso il Vietnam. La maggioranza della popolazione italiana ha iniziato a sentir parlare della Corea del Nord a partire dal ’94 quando è morto improvvisamente il dittatore Kim ll-Sung. In quel momento a Napoli si teneva il G7 che aveva visto riunirsi i grandi capi del mondo e la morte del dittatore coreano aveva sconvolto l’agenda, creando uno squarcio nel velo di oblio che copriva questo paese. In quanto appassionato di estremo oriente e buddismo, seguivo già le vicende nord coreane e nel ’96 ho avuto l’opportunità di partecipare a un viaggio nella Corea del Nord. Al ritorno venne pubblicata una serie di articoli che furono letti dall’ufficio di rappresentanza nord coreano a Roma. Mi dissero che pur non condividendo le affermazioni che avevo scritto, mi invitavano a tornare nel paese per visitarlo individualmente. Da allora quasi ogni anno ho continuato a frequentare la Corea del Nord e dall’inizio degli anni duemila ho iniziato a recarmici per lavoro, facendo visita alla centrale nucleare, ai centri di ricerca scientifici e alle università.

Immagino che tastare con mano la situazione permetta di contestualizzare e farsi un’idea più complessa e sfaccettata di un paese…
Come sempre l’esperienza diretta di un paese permette di farsi un’opinione differente da quella che ci si modella leggendo articoli di giornalisti o analisti che in quel paese non ci hanno mai messo piede perché non hanno mai voluto o potuto visitarlo, contribuendo però a costruire visioni distorte del paese. Kim Jong Un, l’attuale leader, è salito al potere nel 2011 e ha iniziato a rivedere alcuni dogmi che avevano contraddistinto il percorso storico iniziale. L’economia oggi vede una sempre maggiore partecipazione privata. L’80% delle entrate familiari nordcoreane proviene da attività private. Molte famiglie possiedono bar, ristoranti, hotel, piccole imprese artigiane. I contadini possono avere degli appezzamenti di terreno e possono vendere i loro prodotti su mercati privati. C’è anche un forte boom edilizio iniziato nella capitale Pyongyang che però oggi si sta estendendo anche nelle campagne, sempre le ultime a beneficiare di riforme politiche. Ci sono nuove tipologie di appartamenti esteticamente più gradevoli e più funzionali. Politicamente si sta anche affermando una nuova classe di economisti e di tecnici che si sono formati all’estero, nelle università cinesi, russe, vietnamite o anche europee. Si conoscono quindi i principi del libero mercato e nella capitale c’è un’università privata in cui si tengono corsi di economia liberale con professori provenienti da tutto il mondo. Insomma, in Corea del Nord c’è una nuova generazione che sta subentrando e riformando il paese.
Che cosa l’ha colpita di più dei suoi viaggi in Corea del Nord in positivo e in negativo?
In positivo mi ha colpito il continuo cambiamento, di sei mesi in sei mesi veramente la Corea del Nord continua a trasformarsi. Anche la popolazione all’inizio era molto più restia a parlare con gli stranieri, oggi sono loro che si avvicinano per farti domande e parlare. Tutti sanno cosa accade nella Corea del Sud o in Giappone grazie soprattutto alle soap opera sud coreane che spopolano. Anche la stampa di regime nord coreana ha smesso da tempo di dipingere una Corea del Sud povera e retrograda perché sa bene che ormai la popolazione non crede più a queste mistificazioni. L’aspetto negativo è che, come in tutte le civiltà che cominciano ad allentare la morsa autoritaria del governo, comincia a crescere la criminalità. Non certamente a un tasso paragonabile agli altri paesi asiatici, ma comunque è un dato da rilevare. Un altro punto importante è che questa apertura economica rischia di lasciare indietro una grande fetta di popolazione: coloro che non riescono ad avere un ritmo di crescita abbastanza elevato rischiano di trovarsi impreparati e tutto ciò aumenta il divario tra un certo tipo di società e un altro.
I paesi asiatici hanno gestito la seconda ondata della pandemia in modo molto diverso rispetto agli stati occidentali con risultati tendenzialmente migliori (oltre alla Cina, Taiwan…): Quali valutazioni si possono fare in merito alla diversa gestione dell’emergenza?
Noi viviamo in una democrazia che ha un certo tipo di storia e varia anche all’interno di uno stesso sistema. Nel nord Europa il rispetto civico e civile è più sentito, mentre noi, nell’Europa mediterranea, siamo più individualisti, più spreconi e disorganizzati. I recenti decreti varati dal governo in tema di pandemia sono stati visti più come limitazione alla nostra libertà individuale piuttosto che regole necessarie alla salvaguardia della collettività. In più non ci sono state direttive comuni all’interno della Comunità europea e ogni stato ha agito secondo i propri criteri. Le popolazioni dei paesi asiatici, invece, hanno accolto le direttive dei governi centrali con maggiore senso civico. È vero che hanno avuto l’esperienza della SARS nel 2002, però Pechino ha subito imposto il coprifuoco e non ha avuto paura di mobilitare anche l’esercito, suscitando non poche critiche da parte dell’opinione pubblica europea. Inoltre, essendo da sempre popolazioni numerose, erano già abituati all’uso delle mascherine specialmente nelle metropoli, cosa che per noi fino a un anno fa pareva alquanto bizzarra. Infine le civiltà asiatiche sono basate su un caposaldo: il rispetto del bene comune e della collettività. C’è una differenza culturale enorme rispetto alla nostra mentalità: ciò che conta per loro è mantenere l’armonia sociale, mentre da noi la democrazia impone lunghi e talvolta estenuanti dibattiti prima di arrivare a una decisione che, qualunque essa sia, sarà sempre oggetto di contestazioni e rettifiche generando confusione. Il sistema collettivista centralizzato adottato in Asia talvolta funziona meglio del nostro, come nel caso della gestione della pandemia di Covid-19.

L’ultimo libro pubblicato “Versi d’amore e di scienza” coniuga due passioni: la scrittura e la scienza. Come nasce questo libro e che rapporto ha (se ce l’ha) con il momento storico che stiamo vivendo?
In realtà non ha alcuna relazione con il coronavirus però, a ben vedere, trattando di tematiche universali può riguardare chiunque in qualsiasi epoca storica e quindi ben si adatta anche a questo momento di emergenza sanitaria. Il libro nasce proprio dal voler dare un significato al vuoto creato dalla perdita di una persona cara che in questo caso viene colmato, seppur parzialmente, dall’unione di due materie che possono apparire distanti come la poesia con il suo bagaglio di emozioni e la scienza con il suo freddo razionalismo.
I grandi binomi impossibili che Lei prova a coniugare nella sua raccolta di poesie sono: amore e scienza e morte e scienza. È possibile combinare le idee di “amore” e di “morte” (con il vuoto e l’emozione che comportano) con la logica inesorabile della scienza?
Un tempo si tendeva a separare la scienza dalle emozioni. Oggi sappiamo, proprio grazie alla ricerca scientifica, che le due cose sono strettamente legate: ciò che chiamiamo emozioni altro non sono che il risultato di reazioni chimiche all’interno del nostro corpo. Ovvio che detta così perde un po’ di romanticismo, però in “Versi d’amore e di scienza” ho voluto coniugare questi due aspetti: la mancanza di una persona e la ricerca di significato nella morte. Il nostro corpo cambia ogni anno il 99% degli atomi di cui è composto. È come se ogni anno rinascessimo in una persona nuova. Quando moriamo i nostri atomi vanno a comporre altra materia e tra le tante possibilità, c’è anche l’eventualità che vadano a unirsi con gli atomi delle persone a noi care che non ci sono più. In qualche modo quindi potremmo dire che noi, come composto di molecole, continueremo a condividere un percorso di vita con la persona amata, solo in un’altra forma. Questa idea che la morte sia solo la trasformazione in qualcos’altro che continua a vivere è qualcosa di confortante e poetico allo stesso tempo, pur basandosi su presupposti strettamente scientifici.

Nella sua carriera giornalistica, ha intervistato numerosi personaggi di spicco per la politica internazionale. Quale o quali tra i suoi intervistati l’ha colpita di più in bene e in male?
Sicuramente Aung San Suu Kyi (ndr. L’attuale leader del governo birmano). L’ho intervistata per la prima volta nel 1988, al termine del suo comizio inaugurale che diede inizio alla sua carriera politica. Quando cominciai a proporre l’intervista ai giornali, in Italia quasi nessuno conosceva questa donna, ma pochi anni dopo diventò Premio Nobel per la Pace (ndr.1991). Devo dire che non ho mai condiviso l’entusiasmo verso di lei, esaltata quasi come un’icona in Occidente. Era chiaro, dalle sue interviste e dagli incontri che facevo con lei, che non era portata a guidare un paese. Era molto ambiziosa e permalosa, non ha mai accettato confronti e dibattiti con chi la pensa diversamente da lei. Ha negli anni accentrato su di sé le cariche più importanti del paese, ma non ha mai ammesso la palese gestione fallimentare della complessa questione delle minoranze musulmane dei rohingya e di quelle cristiane dei kachin. Da icona dei diritti umani si è rivelata in breve tempo icona di un autoritarismo indifferente ai problemi di integrazione nel suo paese.

Che cosa sente di aver imparato da tutti i viaggi, le culture, le persone incontrate?
Ogni esperienza se ben assimilata è utile a creare una nuova persona, a migliorarne il bagaglio culturale e umano. Occorre assaporare ogni frammento del viaggio, sia positivo sia negativo. Ci vuole tempo per assorbire le emozioni suscitate da certi incontri o certe esperienze, tuttavia lo ritengo un processo necessario per scoprire ogni giorno qualcosa di più su se stessi e poter donare agli altri parte di ciò che si è appreso.
Come è cambiata la sua vita in questo 2020 e che augurio vorrebbe regalare ai soci di Terza Università per il 2021?
Non ho patito troppo il lockdown essendo di natura una persona che sta bene anche da sola. Ho letto e ascoltato musica e, certo, mi sono mancate le escursioni in montagna. Per motivi di lavoro sono riuscito a viaggiare lo stesso nel 2020, ma ho approfittato dei periodi di clausura per terminare cose che procrastinavo da tempo. In questo momento storico si torna a essere protagonisti anche della propria vita interiore: si torna all’essenziale, lasciando da parte tutto il superfluo accumulato negli anni. L’emergenza sanitaria ci permette anche di rivalutare una società come la nostra, fondata su valori che tendiamo a dare come assunti per diritto anche se non è così. Occorre forse imparare a riscoprire e impreziosire di nuovo questi valori sotto l’egida del famoso carpe diem di oraziana memoria. “Vivi questo giorno come se fosse l’ultimo” acquisisce un senso più profondo e radicale proprio in periodi come questo.
Luigi Gatti
Luigi Gatti dopo una vita lavorativa passata tra Italia, Spagna e Giappone, ha iniziato a insegnare lingua e cultura giapponese nella sua città, Bergamo. Appassionato di viaggi a piedi, ha percorso le Vie per Santiago nelle varianti francese, primitivo, portoghese e della Costa, e il Cammino di Shikoku, in Giappone, a cui è dedicato il libro “Il cammino del Giappone. Shikoku e gli 88 templi”, edito da Mursia nel 2017.

Partiamo dalla sua biografia: quando e come è nata la sua passione per il Giappone?
Camminare è una mia grande passione e durante un cammino di Santiago ho conosciuto prima un ragazzo e poi una ragazza giapponesi e sono stato subito affascinato dalla loro visione del mondo, così diversa da quella a cui siamo abituati noi. La ragazza mi chiese: “Perché ti chiami Luigi?” e io non sapevo bene cosa rispondere se non che mio nonno aveva lo stesso nome. Lei si chiama Aki e parlando del suo nome e degli ideogrammi che lo compongono, mi ha spiegato come in Giappone i genitori scelgono un suono a cui corrispondono diversi ideogrammi e in base all’ideogramma scelto il suono acquisisce un significato diverso. Quindi per il suono “A” (di Aki) i genitori avevano scelto l’ideogramma “Asia”, mentre per il suono “Ki” avevano scelto l’ideogramma “Principessa”. Aki significa, scritto in quel particolare modo, “Principessa d’Asia”. Anche solo da questo dettaglio del nome mi si è spalancato davanti un universo che ho voluto assolutamente iniziare a esplorare.
Ha lavorato 5 anni per un’azienda giapponese: che cosa l’ha sorpresa di più dal punto di vista relazionale?
La cosa che mi ha sempre colpito è la differenza tra un giapponese che lavora e un giapponese in pausa. Molto spesso ho notato un cambiamento radicale nel modo di atteggiarsi non appena si cambiava il contesto. Per dire: durante l’orario lavorativo un collega mi dà del “Lei” e fuori dal lavoro mi dà del “tu” cambiando anche radicalmente la sua predisposizione nei miei confronti. Questa sorta di “bipolarità” si verifica in generale in tutti i contesti di vita perché è come se per ogni situazione ci fossero delle norme sociali ben precise a cui il giapponese si adegua pedissequamente. La mia ragazza e il mio migliore amico di allora con me si comportavano in un modo, ma quando li ho fatti conoscere tra di loro hanno assunto delle “pose” e degli atteggiamenti che non avevo mai riscontrato in nessuno dei due. C’è un’espressione in giapponese che racchiude bene questo doppio: Honne e Tatemae (Honne: vero suono; Tatemae: la facciata). Diciamo che ho cercato a lungo un codice interpretativo e di accesso per riuscire a sintonizzarmi sulla stessa lunghezza d’onda, ma è davvero difficile anche perché poi ci sono differenze significative tra il giapponese che vive in città e quello che vive in campagna, per non parlare di quelli che definisco i “diversamente giapponesi” ovvero coloro che hanno vissuto o studiato fuori dal Giappone e che sono quindi più predisposti al dialogo e all’apertura.
Cosa l’ha colpita in senso positivo e cosa in senso negativo della cultura giapponese?
Ciò che più mi manca è il senso civico e la pulizia. Il fatto di sentirsi al sicuro, non perché ci sia l’esercito a ogni angolo della strada, tutt’altro: i livelli di delinquenza in Giappone sono bassissimi e in generale la popolazione è molto rispettosa dell’altro. Sia che mi trovassi in campagna o in città sia che fosse giorno o notte, non ho mai temuto per la mia incolumità. Ciò che invece rimane qualcosa di poco digeribile penso possa essere riassunto in un episodio: ero la guida di un gruppo di milanesi e una volta arrivati in albergo un signore mi aveva chiesto la cortesia di domandare alla reception la sua password per la camera. Ebbene, il receptionist non me l’ha voluta dare. Il signore allora è andato a prenderla per conto suo e poi ha mostrato al receptionist che l’affidava a me. Lui ovviamente non ha fatto una piega, ma il signore milanese gli ha detto “E voi volevate vincere la guerra con gli americani?”. Questo è solo uno degli episodi di rigida burocrazia e formalismo estremo con i quali quotidianamente ci si scontra in Giappone. Un’altra volta dovevo cambiare valuta prima di una partenza e l’impiegato mi ha chiesto i dati dell’albergo dove soggiornavo. Io, però, ero in partenza quindi non avevo nessuna camera prenotata e nonostante glielo spiegassi, lui si limitava a richiedermi gli stessi dati. Finché mi sono rassegnato a dirgli il nome di un albergo a caso e il numero di una camera altrettanto fortuito e l’impiegato soddisfatto li ha annotati e mi ha permesso di fare l’operazione richiesta, consapevole che mi stavo inventando tutto.
Nel nostro immaginario il Giappone è un Paese con grandi paradossi, primo fra tutti: la cultura e le tradizioni millenarie e lo sviluppo tecnologico/capitalistico delle grandi città. Come si coniugano questi due aspetti così contrastanti?
La prima cosa che mi viene in mente per rispondere a questa domanda è una città: Kyoto. È una metropoli immersa nella natura con più di 1600 templi sparsi qua e là. Ti sembra di essere sospeso tra un passato più o meno remoto e un futuro più o meno prossimo. Nella cultura giapponese è sempre stata una priorità la capacità di adattare e migliorare tradizioni e componenti di altre civiltà, prima fra tutte quella cinese da cui hanno preso, per dire, la scrittura e la famosa cerimonia del tè. Non si tratta di una mera imitazione però, i giapponesi tendono a prendere ciò che c’è di buono nelle altre culture e mescolarlo con le proprie usanze per arrivare a un’armonia finale. La questione dell’armonia formale è un caposaldo della cultura giapponese e si esplicita anche nella continua ricerca di coniugare il vecchio e il nuovo, la tradizione millenaria e lo sviluppo tecnologico.

Il Covid-19 ci ha portato a riflettere (finalmente) sul nostro rapporto con la natura e lo sfruttamento eccessivo delle sue risorse. In questo senso ci spiega in sintesi in cosa consiste la filosofia giapponese che sta dietro al termine Shinrin-yoku o Forest Bath che sta cominciando a prendere piede anche qui in Occidente?
Il concetto di Shinrin-yoku o “Bagno di Foresta” implica l’immersione nella natura, il portare la natura nel quotidiano e una filosofia del genere non poteva che nascere in Giappone dove l’attenzione per ciò che ci circonda è massima. Trent’anni fa si sono chiesti perché facesse stare bene camminare nella natura. Per cercare una risposta si sono ritirati sull’isola di Yakushima e hanno creato questa terapia forestale. Adesso in Giappone sono circa 68 le basi forestali e i medici spesso al posto degli psicofarmaci prescrivono alcuni giorni di terapia forestale sovvenzionata dallo stato, come i nostri bagni di fango di una volta. Coerentemente con il concetto di biofilia loro sono arrivati a questa conclusione: l’essere umano si è trasformato in essere urbano in un tempo molto breve rispetto alla storia dell’essere umano. Ci siamo repentinamente allontanati da quel contatto ancestrale con la natura e per la filosofia giapponese questo distacco è alla base di molte delle malattie moderne. Quante ore passiamo davanti a uno schermo e quante nella natura durante la nostra vita? Quindi questa terapia tende a risvegliare i sensi in modo naturale: per una passeggiata di quattro chilometri magari ci si impiegano cinque ore e a noi un’assurdità. Però in quelle cinque ore si è preso il tempo di assaporare i dettagli, fare esercizi di radicamento, respiro e altre pratiche che favoriscono il contatto con la natura.
Nei suoi studi ha approfondito anche il discorso sulla lingua giapponese che meriterebbe un capitolo a parte. Gli ideogrammi affascinano: il gesto del pennello, la bellezza di quei segni neri a noi indecifrabili, il senso che ognuno dei segni racchiude. In che modo questa lingua influisce sul modo stesso di “stare al mondo” dei giapponesi?
Nei miei corsi online sulla lingua giapponese vedo che gli studenti sono quasi subito affascinati perché in effetti bastano poche regole per iniziare a capire subito qualcosa della profondità nascosta negli ideogrammi. E lo studio di una lingua così non è solo fine a se stesso ma è proprio un esercizio mentale di apertura, una vera ginnastica per la mente che comincia a fare percorsi inusuali e a uscire dalle strutture linguistiche predefinite a cui siamo abituati. Per esempio il termine “kotoba” in giapponese significa “parola” ed è composto da “koto” = dire e “ba” = foglia. “trasformare il tuo dire in una foglia”. Il linguaggio viene quindi paragonato a una pianta a cui ogni giorno si aggiunge una foglia, una parola, per arricchirlo. La metafora della natura è sempre molto presente e il linguaggio è parte integrante dello stare al mondo del giapponese, basterebbe vederli scrivere gli ideogrammi per capire che l’automatismo che c’è dietro deriva proprio da una precisa visione del mondo, estremamente diversa dalla nostra.

In questo periodo di restrizioni, di introspezione forzata che cosa può insegnarci la cultura Giapponese?
Anche in questo caso le parole ci vengono in soccorso. Mi viene in mente il concetto di attesa: “matsu”, nel cui ideogramma è celato il movimento, nel senso che proprio graficamente viene rappresentata una strada in movimento. L’attesa quindi non è mai considerata vana, è un momento per prepararsi all’azione. Se non ci fosse il vuoto dell’attesa non potrebbe esserci il pieno dell’azione.
Ha in programma di tornare in Giappone non appena si potrà?
Eh direi di sì! Avevo sette viaggi programmati per il 2020 che sono saltati tutti. Mi manca la scoperta continua che c’è e il mettere in pratica ciò che ho programmato. Uno dei miei lavori è quello di travel designer quindi organizzare viaggi a seconda della committenza. Preparare un viaggio per me è come scrivere un libro per il tipo di studio e ricerca che svolgo, quindi poi è molto bello poter realizzare quanto a lungo progettato.
Che cosa consiglia di visitare a chi non ha mai messo piede in Giappone per prima cosa?
Amo chiamare il Giappone “pianeta stupefacente” perché per me è proprio così. Ha una superficie molto estesa ed è un paese con differenze enormi quindi veramente si può esplorare senza mai stancarsi. Direi comunque di partire con la città di Kyoto per l’incredibile commistione di tradizione, tecnologia e natura che si trova e lascia veramente affascinati. Poi sicuramente anche Osaka, la così detta Tokyo dell’Ovest. Il periodo in cui andare dipende molto dal tipo di esperienza che si vuole fare: meno consigliata è l’estate perché è in generale afosa e calda e direi la classica primavera per il fenomeno dei ciliegi in fiore ma anche l’autunno per il meraviglioso “foliage” degli alberi d’acero.
Un augurio e un consiglio ai soci di Terza Università per questo 2021
Anche in questo caso parto da un’alta parola importante in Giappone che è “dojo” (“do”=viaggio; “jo”=luogo), un luogo che diventa viaggio e un viaggio che diventa luogo. Sfruttare, insomma, questo momento particolare per trasformare il tuo luogo in un viaggio, sia esso un momento di apprendimento, un cammino di crescita personale o un percorso spirituale. Leggere, frequentare corsi online di argomenti che ci hanno sempre interessato ma non abbiamo mai trovato il tempo per approfondire, fare passeggiate, riscoprire l’essenziale. A proposito di letture se il Giappone e la pratica del cammino vi affascina, ricordo il mio libro “Il cammino del Giappone. Shikoku e gli 88 templi” uscito nel 2017 per Ugo Mursia Editore che per i soci di Terza Università posso personalizzare con ideogramma dedicato e spedire a domicilio
Gabrio Vitali
A causa dell’emergenza sanitaria anche i rapporti con i nostri docenti si sono fatti più rarefatti e distanziati, ma non meno speciali. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi qualche intervista con i nostri docenti in occasione della pubblicazione dei loro libri.
Dopo l’intervista a Giampiero Valoti, proseguiamo con Gabrio Vitali
“Sospeso Respiro” a cura di Gabrio Vitali
Editore: Moretti&Vitali
Anno: 2020
pp. 280

Il titolo “Sospeso respiro” vuole indicare quella condizione soffocante di apnea e di ansia che tutti abbiamo vissuto fisicamente e psicologicamente durante la pandemia del virus Covid19. Di come tale condizione si sia tradotta nel respiro, nel battito e nella lingua dei loro versi, danno qui testimonianza poeti, Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Giancarlo Sissa e Giacomo Trinci, proponendo ciascuno una silloge inedita di scritture o riscritture poetiche, composte in tempo di pandemia. A queste quattro raccolte di versi, fa seguito una riflessione di taglio antropologico di Mauro Ceruti, docente di Logica e Filosofia della Scienza presso lo IULM di Milano. Un percorso iconografico di riproduzioni pittoriche, raccontato e commentato da M. Cristina Rodeschini, direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo, impreziosisce di un contrappunto di immagini i diari dei quattro poeti. L’introduzione e i saggi di postfazione alle quattro sillogi, predisposti dal curatore, costruiscono la cornice narrativa e critica che unifica e dà coerenza all’intero racconto del libro.

Lei ha insegnato per molti anni in Italia e all’estero. Qual è la lezione più importante che ha imparato?
Sono convinto che un insegnante insegni sempre se stesso. Per questo i fallimenti sono personali prima che professionali. Devi sorvegliarti e aggiornarti continuamente. Essere umile e autorevole insieme. Soprattutto autentico. Se lo sei, lo saranno con te anche gli allievi. Se ti nascondi dietro il ruolo, anche loro lo faranno. E il loro ruolo di studenti è quello o di esserti sottomessi per forza, o di cercare di fotterti. In entrambi i casi non avranno un rapporto libero e formativo con la scuola. Invece, come ho scritto nel mio Odissei senza nostos, lo scopo vero dell’apprendimento scolastico non è tanto l’imparare questa o quella disciplina, ma soprattutto (attraverso l’apprendimento dell’una o dell’altra materia) il diventare cittadini autonomi e consapevoli, capaci di elaborare con libertà le proprie idee e di sostenerle. A questo lo studio della letteratura si presta moltissimo, oltre che a farti scoprire e imparare cose bellissime e importanti.
Per oltre 30 anni si è occupato di letteratura organizzando manifestazioni culturali che prevedevano l’incontro con scrittori e poeti. Le sembra che Bergamo sia una città recettiva? Cosa si potrebbe fare per migliorare il fermento culturale? (in tempi diversi dalla pandemia globale)
Ho avuto la fortuna di lavorare sempre con grande piacere traendo soddisfazione nella collaborazione con varie amministrazioni pubbliche in Italia come all’estero. Dipendeva molto dalle persone che incontravo nelle istituzioni. Alle manifestazioni che proponevo è sempre venuta parecchia gente e con continuità nei mesi e negli anni. Il messaggio che ho cercato di trasmettere è quello di cultura non come “distrazione”, ma come educazione alla civiltà. Scrivere è capacità non comune di raccontare e raccontarsi, quindi una letteratura è sempre il grande racconto epico che una civiltà ha fatto di se stessa. Delle proprie conquiste, delle proprie sconfitte, dei propri valori. Le parole dei grandi scrittori e poeti servono a farci indagare il funzionamento delle cose della vita e della storia e a farcene definire il senso e il valore, a fornirci nuove chiavi interpretative del mondo. Anziché semplificare, come gli slogan dei socials, dei media o della pubblicità, la letteratura abitua a un pensiero complesso sulla realtà e quindi ci interroga sulle cose della vita e sulle idee che ne abbiamo. E ci aiuta a estenderle e a cambiarle.
“Sospeso respiro” il titolo della silloge da lei curata. Il richiamo alla sintomatologia da Covid-19 o quantomeno all’angoscia nei confronti dell’incertezza è chiara. Ma quale legame c’è tra poesia e pandemia?
Innanzitutto, la poesia ha da sempre un ruolo di consolazione, di antidoto al dolore. Quello che il poeta dice ha un carattere corale e universale, che permette a chi legge di accoglierlo e condividerlo e alleviare così la solitudine o la disperazione che possiamo provare in alcuni momenti della nostra esistenza. La poesia è un luogo di resistenza umana al disorientamento e alla sconfitta, un luogo dove ritrovare l’umanità più vera e autentica, anche quando il mondo intorno ci pare privo di senso. La pandemia ci ha rivelato la condizione di fragilità in cui l’uomo contemporaneo vive, ci ha mostrato come l’umanità stia attraversando una vera crisi evolutiva del rapporto fra la civiltà umana e il pianeta (le crisi economica, ambientale, sociale, politica, demografica, culturale e sanitaria sono solo epifenomeni di questa crisi più globale) per cui a meno di una riorganizzazione radicale di tale rapporto, si rischiano forme d’estinzione di specie e di ecosistemi e viene messa in discussione l’esistenza della vita umana sul pianeta o anche l’esistenza del pianeta come luogo in cui è possibile la vita. La poesia di pandemia ci dà lingua e pensiero per capire, anzi per “sentire”, a fondo tutto questo, partendo da noi, dalla nostra interiorità.
Occorre quindi domandarsi come riorganizzare la civiltà in modo che sia compatibile con il pianeta che ci ospita…
Certo, tuttavia le classi dirigenti sono miopi e impreparate o servono interessi che non spingono a perseguire questa strada; sono legate a modelli di pensiero lineari e ripetitivi. Mi pare di constatare con amarezza che a livello globale classi dirigenti che alimentino e muovano la coscienza delle persone verso questa riorganizzazione radicale non ce ne siano. Tranne alcuni grandi pensatori e papa Francesco, che io sappia. Per questo abbiamo bisogno di vedere cose che prima non vedevamo e imparare a raccontare un altro mondo e un’altra umanità. Occorre educarsi a nuovi linguaggi e a nuovi modi di pensare se stessi e la propria esperienza, individuale e collettiva, del mondo. In questo la poesia svolge un ruolo importante e insostituibile, restituendoti pensieri che non sapevi di avere o facendotene accogliere di nuovi. Per progettare un mondo nuovo occorre avere la lingua e le parole per pensarlo e per raccontarlo. Il linguaggio è il primo strumento, il più importante: nella parola greca “poesia” sono fuse l’idea del dire e l’idea del fare. La poesia è poi un antidoto al consumo di informazione immediata e preconfezionata che non stimola il pensiero e l’immaginazione. Grazie alla sua complessità e ricchezza linguistica essa invita invece a meditare, a interrogarsi, a elaborare idee e sensazioni, a “vederle”…, per poi costruire un pensiero autonomo.

Lorenzo Lotto, “Deposizione di Cristo nel sepolcro”, 1516 Accademia Carrara
Chi sono i quattro autori da lei scelti per la silloge? E come ha avuto origine l’idea di creare una raccolta di poesie?
Nel periodo in cui ho lavorato a Bergamo nei vari festival e manifestazioni culturali, ho avuto modo di conoscere moltissimi grandi poeti e poetesse italiani che ho invitato e presentato nell’una o nell’altra iniziativa; con molti di loro sono rimasto in contatto, e con alcuni, che sono venuti a Bergamo più spesso e con più continuità, siamo diventati molto amici. Durante la quarantena alcuni fra questi ultimi, e cioè Alberto Bertoni, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Giancarlo Sissa e Giacomo Trinci, mi hanno inviato le poesie che scrivevano quasi quotidianamente in quelle settimane e presto mi sono reso conto che quello era del materiale prezioso che andava organizzato e proposto subito alla riflessione del pubblico, perché si trattava di riflessioni e sensazioni importanti e profonde su quello che stava accadendo. Il risultato è questa antologia di quattro raccolte poetiche, a ciascuna delle quali ho aggiunto un saggio che presenta la figura e illustra l’attività poetica dell’autore e ne commenta infine la silloge. Ogni “profilo poetico” è una tappa di un discorso più ampio sulla funzione sapienziale, formativa e civile della poesia e sull’antropologia della scrittura letteraria.
“Sospeso respiro” è un libro collettivo: ad affiancare le poesie e i profili poetici degli autori c’è infatti un percorso iconografico curato dalla direttrice dell’Accademia Carrara, Maria Cristina Rodeschini e una post-fazione dall’eloquente titolo “un groviglio inestricabile” a cura del docente Mario Ceruti. Come mai questa scelta?
Come ho detto, questo libro nasce da un rapporto d’intensa e lunga amicizia. E l’amicizia come la poesia permette di riconoscere l’altro, che arricchisce e completa la tua identità con qualità che prima non avevi o non conoscevi. È stato quindi naturale per me estendere la collaborazione ad altri cari amici. Cristina e Mauro sono stati miei compagni di classe al liceo e da allora siamo in amicizia forte. Lei, ha accettato di proporre la lettura di alcuni capolavori della Carrara, in tema pandemia, come contrappunto agli scritti del libro e, insieme, ha raccontato le sensazioni derivate dal ritrovarsi con un museo deserto. Lui, nel saggio conclusivo “Un groviglio inestricabile” ha analizzato i paradigmi e i modelli culturali, aperti alla complessità, di cui abbiamo bisogno per ripensare la civilizzazione umana del pianeta e per elaborarne una nuova antropologia, anzi una nuova ecologia. Abbiamo insomma tentato di rendere un lavoro di critica letteraria accessibile e accogliente da vari punti di vista e di allargarlo a un discorso più ampio di antropologia della scrittura letteraria e del suo valore “politico”, nel senso proprio di costruzione della “polis”.
In un articolo Lei definisce queste poesie un’“epica corale” che si fa carico di una dimensione collettiva piuttosto che di una intimista. Si tratta di una scelta controcorrente rispetto alla poesia contemporanea che tende a essere massimamente introspettiva e individuale. Rievocare una dimensione collettiva è anche una scelta politica?
Il ruolo della poesia in tempi come questi è anche quello di rieducare al linguaggio e alla consapevolezza necessari per comprendere (e agire nell’epoca che stiamo attraversando. Per questo abbiamo bisogno di una poesia epica, d’impianto corale. Fare poesia significa assumersi delle responsabilità nei confronti del mondo a mio avviso. Che i giovani facciano poesia lirica incentrata sul soggetto può anche andare bene perché sono in una fase di scoperta di se stessi. Detto questo attenzione: l’identità individuale si realizza sempre in quella collettiva. Non a caso questa centralità dell’“io” promossa dalla società individualistica e antropocentrica in cui viviamo ha prodotto una poesia lirico-soggettiva. nella quale il sentire individuale dell’io si fa filtro e metafora del sentire di tutti. Occorre però iniziare, in questi tempi di transizione, a porsi il problema del “noi”: e la poesia epica è proprio questo cantare il “noi”, cioè il sentire della coralità, attraverso la capacità del poeta di farsene voce. La poesia lirica di origine petrarchesca tende a “evadere dalla storia di tutti nell’io” per appartarsi e comprendersi; mentre la poesia epica di origine dantesca “invade l’io con la storia di tutti” per interrogarla e cercare risposte a sé e a tutti. Ecco, ci sono momenti storici in cui è necessaria una poesia di questo tipo. E questo è uno di quei momenti.
La dedica del libro è “A Bergamo, la città ferita”. Stiamo attraversando tempi di grande incertezza e preoccupazione per la nostra salute e per quella del pianeta che ci ospita. Un augurio e un consiglio che vorrebbe dare ai soci di Terza Università
Naturalmente consiglio di leggere tanta poesia! Non sentitevi intimiditi da grandi classici che possono apparire difficili o noiosi, provateci invece! Scoprirete mondi meravigliosi che vi aiuteranno a cambiare o a vivere meglio questo mondo. L’importante è continuare a leggere, bisogna ritagliarsi uno spazio quotidiano da dedicare alla lettura per nutrire la mente così come lo si dedica ai pasti, per nutrire il corpo. Di fatto non è meno essenziale per essere uomini e donne consapevoli.
Giampiero Valoti
Care socie e soci,
a causa dell’emergenza sanitaria anche i rapporti con i nostri docenti si sono fatti più rarefatti e distanziati, ma non meno speciali. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi qualche intervista con i nostri docenti in occasione della pubblicazione dei loro libri.
Iniziamo con Gianpiero Valoti
“Piante e animali del mondo contadino bergamasco” di Gianpiero Valoti
Editore: Lubrina -LEB
Anno: 2020
pp.300
Il nuovo libro del docente di T.u. Gianpiero Valoti è un’incursione ricca di notizie di prima mano nel mondo della tradizione legato alla terra e ai suoi ritmi con frequenti richiami all’eco che questo mondo ha avuto nel campo della cultura popolare e della letteratura. Gli animali della cascina e delle sue pertinenze (la stalla, il porcile, il pollaio, l’aia) e i prodotti indispensabili del campo coltivato, dell’orto, del prato e del bosco sono i protagonisti di altrettanti capitoli che tracciano il profilo della vita quotidiana in un’epoca trascorsa ma non perduta, la cui eco è giunta sino a noi.

Professor Valoti, lei ha insegnato nella scuola primaria e secondaria. Qual è la grande lezione che sente di aver imparato?
Ho insegnato per quarant’anni e ciò che più mi è rimasto è il rapporto reciproco tra chi insegna e chi impara. Per me è sempre stato importante trasmettere la conoscenza con pathos ma per farlo sono necessari fiducia e rispetto reciproco così come autorevolezza e comprensione. Ogni volta che sento qualcuno parlare in francese alla televisione mi chiedo: “Chissà se i miei studenti saprebbero capire ciò che sta dicendo”, spero di aver lasciato qualche traccia, ecco.
Gran parte della sua bibliografia si concentra su quella che viene definita la “civiltà bergamasca”. Perché considera importante mantenere viva la memoria delle abitudini del passato, specialmente quelle relative alla vita agricola?
Quello che mi ha guidato non è una nostalgia per il “bel tempo andato” anche perché la vita contadina era dura, faticosa. Non voglio riesumare nessun idillio bucolico, insomma. Quello che mi interessa è la memoria storica; la conoscenza è importante per capire e andare avanti. Ho cercato di mostrare non l’idea dell’agricoltura e del mondo contadino in generale, ma degli uomini e delle donne che queste vite le hanno vissute davvero. Io sono del ’49 e in questo libro ho voluto mettere tutto quello che nel tempo ho imparato sul mondo contadino bergamasco, la considero un po’ la mia eredità per quelli che verranno affinché queste cose non vengano perse.
Che legame hanno queste tematiche con la sua storia personale?
Io l’ho conosciuta la vita agricola, mio papà era mezzadro, l’ultimo retaggio di un’economia feudale. Sono quindi nato nel mondo contadino e da subito ho capito il legame profondo tra la terra e la vita. La vita contadina autentica è fonte di conoscenza e permette di instaurare un rapporto armonico con la natura. Il mio interesse per queste tematiche è sfociato innanzitutto in una ricerca su Nembro: ho intervistato più di 150 persone sulle condizioni di vita dell’Ottocento ed è stata una vera rivelazione di un mondo sconosciuto che però era importante ricordare. Poi io ora vivo in campagna, allevo e coltivo e sono riuscito a realizzare un sogno, quello di avere un pezzo di terra mio. Qualcosa che mio padre ha desiderato per tutta la vita.

Asini e capre: due animali legati a proverbi popolari. Qual è il legame di questi animali con la cultura bergamasca?
In generale tutti gli animali legati alla dimensione contadina sono forieri di proverbi o espressioni idiomatiche particolari, anche in bergamasco. “Contà come l’ömbra d’ün azen”, “Dà intend piö bö che ache”, “Al comincia a répulas sö”, “l’asen quand l’à mangiat, el volta’l cul a la treis”. Molto spesso a questi animali si davano caratteristiche antropomorfe ed erano presenze importanti e vive anche nella lingua stessa. L’aspetto fisico e geologico della nostra provincia – un terzo pianura, un terzo collina, un terzo montagna, – permetteva grande varietà sia di animali sia di coltivazioni e di strumenti agricoli.
Ci descriva qualche aneddoto in cui sono protagonisti animali che secondo lei ben rappresentano lo spirito bergamasco.
L’Italia era divisa in due, il Sud con le terre dell’olio e il Nord con le terre del lardo: Bergamo era sicuramente una terra del lardo perché era un alimento che insieme alla polenta faceva parte della dieta quotidiana delle persone, così come il maiale aveva una grande importanza nella vita delle persone. Negli anni ’50 poi facevano diversi concorsi per le vacche e ogni famiglia contadina ne possedeva una, massimo due e quindi tutte le vacche avevano un nome proprio come la Bionda, la Garibalda e nelle stalle le si chiamava per nome. C’era un rapporto familiare e domestico con gli animali, si era orgogliosi di poterli far gareggiare in questi concorsi. Il linguista e storico Antonio Tiraboschi poi raccontava che un giorno all’anno, l’Epifania, gli animali della stalla parlavano tra di loro mentre i ragazzi aspettavano il passaggio dei Re Magi che con i loro cammelli “si fanno alti, alti, piccini, piccini e rimpinzano le calze di dolci e frutti”.
Nel libro si accenna anche a diversi record su cui l’agricoltura e l’allevamento bergamasco possono contare. Ce ne dice qualcuno di insolito?
La provincia di Bergamo è stata per molto tempo al primo posto nella produzione di seta e di bachi da seta. Fino al Cinquecento per via dei patti di mezzadria era obbligatorio che ogni colono allevasse dei bachi. C’erano numerose filandre e filatoi, poi c’è stato un momento di crisi per via della peste di manzoniana memoria. Nel Settecento invece si assiste a un vero e proprio boom del gelso per i bachi. I contadini lavoravano duramente per un mese e mezzo, però poi la resa era cospicua. Nel Seicento la coltivazione del miglio viene rimpiazzata con quella del granoturco che aveva lo stesso ciclo colturale ma una maggiore produttività e minori spese. C’è poi tutta la storia della patata, che meriterebbe un libro a parte. Venne introdotta faticosamente agli inizi dell’Ottocento da un ex ufficiale svizzero delle armate napoleoniche ritiratosi a Selvino. All’inizio c’era gran diffidenza perché i contadini sono notoriamente “gente chiusa”. Ci si accorse ben presto, però, che nei momenti di carestia la patata è una vera manna perché crescendo sottoterra è protetta dalle intemperie stagionali e ha una resa molto maggiore dei cereali.

Stiamo attraversando tempi di grande incertezza e preoccupazione per la nostra salute e per quella del pianeta che ci ospita. Un augurio che vorrebbe dare ai soci di Terza Università
State al sicuro e abbiate cura di voi! È importante anche recuperare un rapporto con la natura che sia pulito. Per questo ho scritto questo libro: è impossibile tornare al passato e non voglio dare l’impressione di essere un nostalgico, però dal passato si può imparare qualcosa di utile per provare a navigare in questo futuro così incerto. Una cosa che possiamo riscoprire è, per esempio, l’importanza di un rapporto in armonia con la natura, in cui ci si inserisce rispettandola.
